“La storia passa sulle
nostre teste senza che nulla si possa fare per modificarla o arrestarla!"
Così ho scritto nella presentazione di questa sezione: "...
nulla si possa fare ...".
Impersonalmente la frase regge, ma se si ammettesse l'esistenza
di un soggetto capace di tanta potenza, chi potrebbe essere?
Con riferimento all'episodio della scheggia che non ha colpito
papà mio
e dell'altra scheggia che ha colpito un signore sconosciuto forse pure
lui padre di altrettanta prole, cosa è successo?
C'è una prole più fortunata di un'altra?
L'artigliere che ha sparato il colpo di cannone non entra nel gioco?
Quale obiettivo costui doveva centrare nella direzione indicata
dal comando?
L'obiettivo era anche la tesa di un cappello?
Prima del suo verificarsi, questo episodio, doveva succedere o
poteva succedere?
Per una situazione analoga rinvio alla lettura di un episodio
in "Favole e raccontini
brevi/Tempo di aratura" riguardante Giaruul che,
durante un operazione di pattugliamento col suo amico Gigiola,
al tempo dell'occupazione militare italiana in Grecia, si trovarono
nella necessità di sparare il primo colpo di fucile.
Episodi del genere se ne potrebbero citare a migliaia, anche non
ricercandoli necessariamente in tempo di guerra, ma termino qui
gli interrogativi perché non
voglio emulare Italo Calvino che è un mito nel rappresentare
l'attimo fatale: nel tutto, l'evento si esaurisce in un crescendo
verso una situazione di inesauribile tenzone tra casuale e causale;
tra dimensioni temporali e spaziali dall'infinito al nulla!
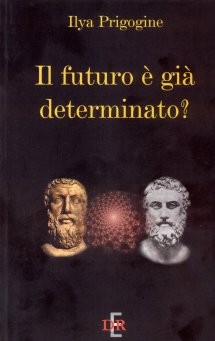 Non scriverei queste cose, oppure le scriverei in modo diverso,
se non avessi appena letto "Il futuro è già determinato?" di Ilya
Prigogine, appena uscito da Di Renzo Editore. Non scriverei queste cose, oppure le scriverei in modo diverso,
se non avessi appena letto "Il futuro è già determinato?" di Ilya
Prigogine, appena uscito da Di Renzo Editore.
Già il titolo ed il volto dei due filosofi greci sulla
copertina ha esercitato su di me un effetto calamita: il mio entusiasmo è salito
alle stelle quando ho letto, a pagina 32, la dichiarazione dell'autore
di non sapere "quale sarà la posizione della luna tra
un milione di anni" ma che "l'esistenza di milioni
di insetti che osserviamo è una
prova di quella che potremmo chiamare la creatività della
natura."
L'autore, nel contesto del periodo nel quale è inserita
la breve frase qui riportata, richiama il pensiero di due grandi
filosofi: Parmenide ed Eraclito.
Parmenide insisteva
che non c'è niente di nuovo, che ogni cosa esiste ed esisterà per
sempre.
Eraclito insisteva sull'idea del cambiamento.
Un dilemma che ha interessato i filosofi sino ad oggi
e che non ha trovato soluzione: ha ragione Parmenide, oppure Eraclito?
Prigogine in poche pagine vuole dimostrare che il dilemma può essere
inserito in una cornice matematica esatta.
Non voglio riassumere
lo svolgimento del tema dal punto di vista matematico e per questo,
chi ha interesse faccia come me: spenda € 8,50
comprando il libro presso: www.internetbookshop.it e si convinca,
sempre come me, che, le sue argomentazioni sono decisamente efficaci
nel confutare certe tendenze di pensiero che, con caparbia pervicacia,
vogliono sopravvivere. Tento di rappresentare, a modo mio, le conseguenze di quanto
espone!
Innanzi tutto, sembra che il dilemma Parmenide - Eraclito non
sussista. Entrambi hanno ragione: l'unico a rimetterci un po' le
penne, a mio parere, è Platone
che pasticcia le cose tentando di risolvere il dilemma con "l'essere" e "il
non essere" per dire che il cambiamento è insito in
ciò che è e che non appare. Platone sostanzialmente dice
che bianco non è nero; bontà non è cattiveria e da
tutto ciò che è preesistente, nasce il cambiamento
dopo uno squilibrio ovvero una lotta insita in tutte le cose create.
Le due concezioni sono vere nell'ambito di ciò che si vuole
osservare.
La natura si manifesta sotto varie forme ed ognuna di queste ha
caratteristiche sue peculiari nell'ambito delle dimensioni che
si prendono a base dell'osservazione.
Siccome non sono un fisico, né un matematico, ma un modestissimo
speculatore nell'osservazione di fenomeni naturali, cerco di chiarirmi
le idee esaminando, sull'onda del pensiero di Ilya Prigogine, se
quei fenomeni, oggetto di studio della sociologia e della psicologia
abbiano, nel fondo, un comportamento affine.
Mi pongo una domanda: tutti i fenomeni compresi nelle scienze
citate, sono integrabili? Ovvero stabilito un principio scientifico
come quelli osservati nella fisica classica, esiste per il tempo
una direzione privilegiata sulla quale fare previsioni esatte anche
per l'economia?
Se fosse così la risposta alla domanda fatta dall'autore nel titolo
della propria opera sarebbe: il futuro è determinato nella misura
in cui si possa prevedere la data della scomparsa universale della povertà,
ad esempio.
Ilya Prigogine ci ricorda che, "per la fisica
classica, il futuro ed il passato giocano lo stesso ruolo e tutto procede
in modo predeterminato e che, per la termodinamica, tutto va verso la morte:
la morte termica".
Così si prevede anche la morte fisica di una persona, aggiungo io,
con tutto l'ausilio della scienze medica (causalità) e statistica
(causalità) che, dai tempi dei nostri antichi e celebri
filosofi, hanno progredito all'inverosimile.
Quindi, anche il benessere universale?
Nel modo classico con cui gli eventi si susseguono con regolare
continuità si arriva solo a sintetizzare la storia universale
in: nacque, visse e morì.
Ovvero nel senso pessimistico come in un processo di termodinamica.
Il succedersi delle civiltà dimostrano che una certa concezione
deterministica della storia ha un fondamento logico, ammesso però che
ogni storia sia fine a se stessa.
In realtà le regolarità storiche sono interrotte da perturbazioni,
da flussi provocati dai sistemi esterni a quelli osservati e che creano
nuovi cicli di fenomeni la cui evoluzione è imprevedibile in
relazione all'esperienza passata.
Ogni fenomeno vive all'interno di un sistema che non
può essere spiegato dentro il sistema stesso: ad esempio la relazione 1+1=2 non può essere dimostrata dall'aritmetica (ricordate l'episodio di Achille e la tartaruga?), come l'esistenza di Dio non può essere spiegata né dalla teologia né dalla filosofia perchè trattasi di verità autoreferenti non dimostrabili come dice Goedel nel suo teorema.
Nell'ambito dei rispettivi sistemi, queste identità sono
atti di fede. Il fatto che la prima relazione sia stata dimostrata
in matematica analitica non comporta il fatto che si debba anche
dimostrare che per credere in Dio debba esserci una dimostrazione.
La lezione di S. Tommaso apostolo c'insegna qualcosa al riguardo:
vedendo il costato ferito del Cristo ha creduto, e quando ha creduto
avrebbe anche potuto (come facoltà - libertà - libero
arbitrio) continuare a non credere.
Gli egiziani hanno costruito le piramidi prima che Pitagora
facesse la dimostrazione del suo famoso teorema!
Quindi occhio ai flussi, alle discontinuità, alle tendenze che si susseguono nelle fasi di regolarità. Sono i fatti entelechiani, da me rinominati “follie”, che possono darci potenti segnali degli andamenti futuri.
Ricordo che dai tempi del Trattato di Yalta, si diceva che l'impero sovietico era un colosso dai piedi d'argilla.
Ci sono voluti quasi cinquanta anni perché crollasse il muro di Berlino e chi sopravvisse da allora con questa convinzione, ebbe la soddisfazione di dire che aveva ragione.
Ilya Prigogine sembra convinto che si possa arrivare alla integrazione, ma, per ora, siamo fermi alla biologia e tra la sociologia e la psicologia. Forse nuove scoperte nel campo della fisica, porteranno nuovi elementi per fare previsioni temporali. Per ora contentiamoci di ciò che sappiamo già del futuro che vedo in una sua evoluzione in senso ottimistico.
Quale futuro?
Non quello della costruzione di un nuovo muro di Berlino!
Ilya Prigogine dà preziose indicazioni, al riguardo e riporto, per intero quanto dice nelle conclusioni a pagina 45 del suo libro più volte qui ricordato.
"Arriviamo così ad una diversa concezione della realtà.
Laplace e Einstein credevano che l'uomo fosse una macchina all'interno della macchina cosmica.
Spinoza affermava che senza saperlo siamo tutti macchine, cosa che non sembra particolarmente soddisfacente. Tuttavia, nel descrivere il nostro universo evoluzionistico, abbiamo fatto solo i primissimi passi. La scienza e la fisica sono ben lontane dall'essere complete, come invece qualche fisico teorico vuole farci credere.
Al contrario, ritengo che i vari concetti, che ho cercato di descrivere in questo mio intervento, dimostrano che siamo solo all'inizio. Non sappiamo esattamente cosa corrisponde al Big Bang, non sappiamo cosa determina le famiglie delle particelle, non sappiamo in che direzione si muove l' evoluzione biologica.
Posso concludere il mio intervento con qualche osservazione generale. La fisica del non equilibrio ci ha fornito una migliore comprensione del meccanismo della comparsa degli eventi. Gli eventi vengono associati alle biforcazioni. "Il futuro è già determinato?". Soprattutto in quest'epoca di globalizzazione e di rivoluzione basata sulle reti, il comportamento a livello individuale è il fattore chiave nel plasmare l'evoluzione dell'intera specie umana, proprio come poche particelle possono alterare l'organizzazione macroscopica della natura e dar luogo alla comparsa o scomparsa di strutture dissipative. Il ruolo degli individui è più importante che mai e questo ci porta a credere che alcune delle nostre conclusioni rimangano valide nelle società umane.
Una famosa affermazione di Einstein dice che il tempo è "un'illusione". Einstein aveva ragione per i sistemi integrabili ma il mondo intorno a noi è essenzialmente formato da sistemi non integrabili. Il tempo è la nostra dimensione esistenziale. I risultati qui riportati dimostrano che il conflitto tra Parmenide e Eraclito può essere estrapolato dal contesto metafisico e formulato nei termini della moderna teoria dei sistemi dinamici."
Con quanto precede concludo col dire che nell’ambito dei rapporti umani non è tanto importante il fattore deterministico, quanto, invece l’evolversi degli eventi con tutto il loro intrecciarsi di correlazioni e di discontinuità:
- le prime, sottoposte ad attento esame danno traccia alle tendenze,
- le seconde con tutto il loro carico di indeterminazione hanno bisogno di essere inquadrate in studi specifici per accertare quanta parte deriva dall’immanente e quanta parte dal trascendente.
Il problema è da sempre lo stesso, ma l’approccio, seguendo la metodologia proposta, potrebbe dare interessanti risultati.
Roma 23 aprile 2003
Revisione 6 maggio 2004
Revisione del 18 novembre 2009 |

